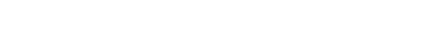© Sigmagazine, rivista d'informazione specializzata e destinata ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica - Best edizioni srls, viale Bruno Buozzi 47, Roma - P. Iva 14153851002 - Direttore responsabile: Stefano Caliciuri - Redazione: viale Angelico 78, Roma - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma al numero 234/2015 - Registro Operatori della Comunicazione: 29956/2017
Siamo alle solite: il mese di ottobre è il mese utilizzato dai detrattori per portare avanti un attacco frontale ai voporizzatori personali. È un film già visto molte volte, è una consuetudine; ciclicamente la storia si ripete, le notizie pubblicate, sulla stampa laica, hanno un andamento di tipo sinusoidale: oggi ci troviamo nella curva che sta al di sopra dell’asse delle ascisse, attendiamo con fiducia che si compia il ciclo completo per poi ritornare nel previsto periodo di pace scientifica. Ma oramai i vapers sono abituati, proprio come i microrganismi verso gli antibiotici. Anche loro hanno sviluppato una certa resistenza e sono diventati più forti e meno permeabili alle strumentalizzazioni provacatorie.
 Nei giorni scorsi è apparsa su tutti i maggiori media italiani uno studio condotto dalla Duke University, secondo cui nel vapore delle sigarette elettroniche ci sarebbe una sostanza tossica sino ad oggi sconosciuta. Se fosse davvero così la scoperta sarebbe meritoria del premio Nobel. Ma vediamo invece nel dettaglio di cosa si tratta. Gli acetali incriminati si formano normalmente a partire da aldeidi e/o chetoni in presenza di alcooli, in ambiente acido attraverso un passaggio intermedio con formazione di emiacetali, (questi sì che sono più difficili da isolare in quanto instabili).
Nei giorni scorsi è apparsa su tutti i maggiori media italiani uno studio condotto dalla Duke University, secondo cui nel vapore delle sigarette elettroniche ci sarebbe una sostanza tossica sino ad oggi sconosciuta. Se fosse davvero così la scoperta sarebbe meritoria del premio Nobel. Ma vediamo invece nel dettaglio di cosa si tratta. Gli acetali incriminati si formano normalmente a partire da aldeidi e/o chetoni in presenza di alcooli, in ambiente acido attraverso un passaggio intermedio con formazione di emiacetali, (questi sì che sono più difficili da isolare in quanto instabili).
Gli aromi, secondo la TPD, devono essere puliti dalle aldeidi, anche se non è escluso che si possano formare per pirolisi durante riscaldamento del liquido: ecco perché la temperatura di vaporizzazione è un parametro che bisogna tenere bene sotto controllo.
 In ogni caso gli acetali non sono assolutamente nuove molecole e sono ben rappresentati in natura, per esempio nella buccia dell’uva e in parte anche nella polpa. Sono proprio loro che conferiscono al vino stesso il caratteristico profumo. Questi sono detti acetali del vino e dell’uva, mentre quelli che eventualmente si formeranno negli eliquids li chiameremo acetali del PG o degli eliquids; dove sta la novità? Dove sta la scoperta?
In ogni caso gli acetali non sono assolutamente nuove molecole e sono ben rappresentati in natura, per esempio nella buccia dell’uva e in parte anche nella polpa. Sono proprio loro che conferiscono al vino stesso il caratteristico profumo. Questi sono detti acetali del vino e dell’uva, mentre quelli che eventualmente si formeranno negli eliquids li chiameremo acetali del PG o degli eliquids; dove sta la novità? Dove sta la scoperta?
Teniamo sempre presente che in Europa, le aldeidi e tanti altri composti che non sono indicati in etichetta (perché non presenti) sono sempre riportati nelle analisi (quali-quantitative) delle emissioni degli eliquids e sono a disposizione delle autorità di ogni Stato europeo. Se così non è invece previsto in America, non è un problema italiano, così come è pomposamente strumentalizzato. L’altro problema di cui sempre si parla, cioè l’utilizzo degli eliquids da parte dei minori, si risolve semplicemente adottando un divieto specifico come esiste ormai da anni in tutta Europa.
Un’altra affermazione contestabile nello studio statunitense è che gli acetali del PG favorirebbero l’asma. A tal proposito ricordiamo che sono stati pubblicati studi, anche del professor Polosa, proprio sulla non interferenza del vaping in pazienti affetti d’asma bronchiale che anzi questi asmatici potrebbero perfino svapare e non certamente fumare.
 L’irritazione alla gola di cui si parla, a mio avviso, potrebbe essere causata, più verosimilmente, da un titolo elevato di nicotina o anche dalla scarsa qualità di quest’ultima.
L’irritazione alla gola di cui si parla, a mio avviso, potrebbe essere causata, più verosimilmente, da un titolo elevato di nicotina o anche dalla scarsa qualità di quest’ultima.
Ricordiamo che carbonili, acetali, acroleina (acrilaldeide o propenale), benzopirene, nitrosamine e similari sono argomenti che per chi studia i vaporizzatori e gli eliquids non sono certamente nuovi, ma ben conosciuti e la ricerca applicata nel settore vaping è impegnata quotidianamente a ricercare nuove strategie e sistemi volti a ridurre al massimo il rischio di tossicità dei sistemi di svapo. Per questo motivo parliamo di riduzione del danno e non di azzeramento del danno. Ma quando si dice riduzione del danno, parliamo di un enorme riduzione che si attesta a valori pari al 95% rispetto al fumo di sigaretta.
Seppure, in certe condizioni di temperatura e pH e in presenza di alcune molecole (aldeidi, chetoni e alcoli) si dovesse formare un “acetale profumato del PG” durante la nebulizzazione di un eliquids, vi siete mai chiesti quante centinaia o migliaia di acetali e di veleni puzzolenti si formano dalla combustione di una sigaretta?